
Ouverture: molte cose cambiano…
Una volta, la struttura di base del patriarcato era la famiglia nucleare e chiedere la sua abolizione è stata una richiesta radicale. Ora le famiglie sono sempre più frammentate: nonostante questo, quanto, di fondo, si è ampliato il potere delle donne o l’autonomia dei bambini?
Una volta, i media tradizionali consistevano di pochi canali televisivi e radiofonici. Non solo si sono moltiplicati all’infinito, ma sono stati soppiantati da forme di media come Facebook, Youtube e Twitter. Ma questo ha fatto fuori il consumo passivo? E, strutturalmente parlando, quanto più controllo hanno veramente gli utenti su questi formati?
Una volta, i film rappresentavano l’epitome di una società basata sull’essere spettatori, oggi i videogiochi ci permettono d’essere le stelle di epici “sparatutto”, e l’industria dei giochi da consolle ha lo stesso giro d’affari di Hollywood. In un pubblico che guarda un film, ognuno è solo, il massimo che può fare è fischiare se la trama lo offende. Nei nuovi giochi elettronici invece, è possibile interagire in tempo reale con versioni virtuali di altri giocatori. Ma è una maggiore libertà? Vuol dire stare più insieme?
Una volta, si poteva parlare di una cultura sociale e culturale tradizionale e la stessa sottocultura pareva sovversiva. Ora, per i nostri capi la “diversità” è un bene prezioso, e la sottocultura un motore essenziale della società dei consumi: quante più identità, tanti più mercati.
Una volta, la gente cresceva nella stessa comunità di genitori e nonni, e viaggiare poteva essere considerato una forza destabilizzante, capace di interrompere configurazioni sociali e culturali statiche. Oggi la vita è caratterizzata da un costante movimento nel quale la gente lotta per stare al passo con le richieste del mercato; al posto di configurazioni repressive, abbiamo una transitorietà permanente e l’atomizzazione universale.
Una volta, i lavoratori si fermavano per anni o decenni nel solito impiego, sviluppando legami sociali e punti di riferimento comuni tali da rendere possibili i sindacati vecchio stile. Oggi, l’occupazione è sempre più temporanea e precaria, e sempre più lavoratori passano dalle fabbriche e i sindacati al settore dei servizi e alla flessibilità obbligatoria.
Una volta, il lavoro salariato era una sfera distinta della vita, era facile riconoscerlo e ribellarsi contro i modi in cui veniva sfruttato il nostro potenziale produttivo. Ora, ogni aspetto dell’esistenza sta diventando “lavoro”, nel senso di attività che produce valore per l’economia capitalistica: guardando il proprio account di posta elettronica si aumenta il capitale di coloro che vendono pubblicità. Al posto di ruoli distinti e specializzati nell’economia capitalistica, vediamo sempre più la produzione collettiva e flessibile di capitale, in gran parte non pagata.
Una volta, il mondo era pieno di dittature nelle quali il potere era chiaramente esercitato dall’alto e poteva essere contestato in quanto tale. Ora stanno cedendo il passo a democrazie che sembrano includere più persone nel processo politico, legittimando così i poteri repressivi dello Stato.
Una volta, l’unità essenziale del potere statale era la nazione, e le nazioni competevano tra loro per far valere i propri interessi individuali. Nell’era della globalizzazione capitalista, gli interessi del potere statale trascendono i confini nazionali e il modello dominante di conflitto non è la guerra, ma il controllo poliziesco. A volte viene utilizzato contro le nazioni canaglia, ma è attuato continuamente nei confronti delle persone.
Una volta, si poteva disegnare il confine, anche se arbitrario, tra il cosiddetto Primo e Terzo Mondo. Oggi coesistono in ogni metropoli, e la supremazia bianca, negli Stati Uniti, è gestita da un presidente afro-americano.

Lottando sul nuovo terreno
Al volgere del secolo, potevamo immaginare l’anarchismo solo come una diserzione da un ordine sociale onnipotente.
Dieci anni fa, da giovani folli idealisti, pubblicammo Days of War, Nights of Love, insperatamente uno dei libri anarchici più venduti nel decennio successivo. Se pur controverso all’epoca, in retrospettiva si rivelò ragionevolmente rappresentativo di quanto molti anarchici andavano chiedendo: immediatezza, decentramento, autoproduzione quale pratica di resistenza al capitalismo. Aggiungemmo alcuni elementi di provocazione: anonimato, plagiarismo, illegalità, edonismo, rifiuto del lavoro, delegittimazione della storia a favore del mito, l’idea che la lotta rivoluzionaria potesse essere un’avventura romantica.
Il nostro approccio si inscriveva in un contesto storico preciso. Il blocco sovietico era da poco crollato e le imminenti crisi politiche, economiche ed ecologiche non si erano ancora profilate; il trionfalismo capitalista era al suo apice. Volevamo scalzare i valori borghesi, perché parevano sintetizzare le aspirazioni di ogni persona; presentammo la lotta anarchica come un progetto individuale, perché era difficile immaginare qualcosa di diverso. Quando il movimento antiglobalizzazione prese slancio negli Stati Uniti e lasciò il passo al movimento contro la guerra, giungemmo a concettualizzare la lotta in un’ottica più collettiva, se pur derivante da una decisione personale di opporsi a uno status quo profondamente radicato.
Oggi buona parte di ciò che proclamavamo è acqua passata. Il capitalismo è entrato in uno stato di crisi permanente, le innovazioni tecnologiche sono penetrate sempre più a fondo in ogni aspetto della vita, e l’instabilità, il decentramento e l’anonimato hanno finito per caratterizzare la nostra società, senza portarci minimamente più vicino al mondo dei nostri sogni.
Spesso i radicali pensano di trovarsi in una landa desolata, senza contatti con la società, quando in realtà ne costituiscono l’avanguardia – pur non avanzando necessariamente verso le mete cui anelano. Come sostenemmo poi nel n. 5 di Rolling Thunder, la resistenza è il motore della storia: genera sviluppi sociali, politici e tecnologici, costringendo l’ordine prevalente a innovarsi di continuo per aggirare o assimilare l’opposizione. Possiamo pertanto contribuire a trasformazioni formidabili, senza mai raggiungere il nostro obiettivo.
Con questo non vogliamo attribuire ai radicali la capacità di determinare gli eventi mondiali, semmai affermare che spesso ci ritroviamo inconsciamente al loro apice. Rispetto all’immensità della storia, qualunque azione è infinitesimale, ma il concetto stesso di teoria politica implica che è ancora possibile sfruttare questa capacità di agire in maniera significativa.
Quando studiamo le singole strategie di lotta, dobbiamo fare attenzione a non avanzare rivendicazioni che possano essere smontate da riforme parziali, onde evitare che i nostri oppressori neutralizzino i nostri sforzi limitandosi a fare qualche semplice concessione. Alcuni esempi di progetti radicali che possono essere facilmente recuperati sono talmente ovvi che è quasi una banalità ricordarli: il feticismo della bicicletta, la tecnologia “sostenibile”, gli acquisti “a kilometro 0” e altre forme di consumo etico, il volontariato che mitiga le sofferenze provocate dal capitalismo globale senza metterne in discussione le cause.
Ma questo fenomeno può verificarsi anche a livello strutturale. Dobbiamo esaminare i modi in cui abbiamo reclamato una trasformazione sociale generale che potrebbe avere luogo senza scuotere le fondamenta del capitalismo e della gerarchia, cosicché la prossima volta i nostri sforzi possano portarci fino in fondo.
Oggi deve diventare la pista di decollo da un mondo in rovina.
Non lavorare – Quale lavoro?
La provocazione che caratterizzò la nostra gioventù fu prendere alla lettera il motto situazionista NON LAVOREREMO MAI. Alcuni di noi decisero di provare sulla propria pelle se fosse realmente possibile. Questo atto di spavalderia rivelò tutto l’ingegno della spontaneità giovanile, e tutte le sue insidie. Anche se molti altri avevano percorso questa via in passato, per noi fu come essere i primati lanciati per primi nello spazio. In ogni caso, facevamo qualcosa, prendevamo il sogno della rivoluzione sul serio, come un progetto che si può avviare immediatamente nella propria vita, con – come si diceva allora – un aristocratico disprezzo per le conseguenze.
È forte la tentazione di snobbarla come semplice rappresentazione artistica Eppure dobbiamo intenderla come un primo tentativo di rispondere alla domanda con la quale i presunti rivoluzionari si confrontano tuttora negli Stati Uniti e in Europa occidentale: che cosa può mettere fine alla nostra obbedienza? Gli insurrezionalisti contemporanei cercano di porsi lo stesso interrogativo oggi, anche se le risposte offerte da molti di loro sono altrettanto limitate. Di per sé, né la disoccupazione volontaria, né gli atti di vandalismo gratuito sembrano in grado di scuotere la società e indirizzarla verso una situazione rivoluzionaria. Nonostante tutto, rimaniamo convinti della nostra intuizione iniziale: ci vorrà un nuovo modo di vivere per creare una situazione del genere; non si tratta soltanto di dedicare un numero sufficiente di ore ai soliti vecchi compiti. Il tessuto essenziale della nostra società – la cortina che ci separa da un mondo diverso – è soprattutto il buon comportamento degli sfruttati e degli esclusi.
Nel giro di un decennio la storia ha reso obsoleto il nostro esperimento, accogliendo, per assurdo, la nostra rivendicazione di una classe inadatta al lavoro. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, presunto al 4% nel 2000, alla fine del 2009 era salito al 10% – contando soltanto le persone che cercavano attivamente un impiego. Gli eccessi della società dei consumi una volta offrivano a chi se ne chiamava fuori un certo margine di errore; la crisi economica ha eroso questo margine e ha conferito alla disoccupazione un sapore decisamente involontario.
È ormai evidente che il capitalismo non ha più bisogno di noi di quanto noi abbiamo bisogno di lui. E questo non vale soltanto per gli anarchici refrattari, ma per milioni di lavoratori negli Stati Uniti. Nonostante la crisi economica, le grandi multinazionali continuano a registrare enormi profitti, ma invece di usare queste entrate per assumere più dipendenti, investono nei mercati esteri, acquistano nuove tecnologie per ridurre il fabbisogno di manodopera, e distribuiscono i dividendi agli azionisti. Ciò che fa bene alla General Motors non fa bene al paese, insomma. Le aziende statunitensi più redditizie stanno ora trasferendo la produzione e i consumi all’estero, nei “mercati in via di sviluppo”.
In questo contesto, la cultura dell’autoesclusione assomiglia un po’ troppo a un programma volontario di austerità; ai ricchi conviene, se rifiutiamo il materialismo consumistico, dato che in ogni caso non c’è abbastanza per tutti. Alla fine del Ventesimo secolo, quando la maggior parte delle persone si identificava con la propria professione, il rifiuto di abbracciare il lavoro quale forma di realizzazione personale esprimeva il rigetto dei valori capitalistici. Oggi il lavoro saltuario e l’identificazione con le proprie attività ricreative, invece che con la carriera professionale, sono ormai normalizzati come condizione economica piuttosto che politica.
Il capitalismo sta facendo propria anche la nostra convinzione che le persone dovrebbero agire secondo la propria coscienza, invece che per un salario. In un’economia che offre abbondanti possibilità di vendere il proprio lavoro, è ragionevole sottolineare l’importanza di altre motivazioni per svolgere un’attività; in un’economia in crisi, essere disposti a lavorare gratuitamente ha implicazioni diverse. Lo Stato, per compensare gli effetti deleteri del capitalismo, fa sempre più assegnamento sulla stessa etica dell’autoproduzione che un tempo animava il movimento punk. Lasciare che i volontari ambientalisti ripuliscano la chiazza di petrolio provocata dalla BP costa molto meno di farlo fare a dipendenti retribuiti, per esempio. Lo stesso vale per Food Not Bombs, se lo si considera un programma di beneficenza anziché un metodo per generare flussi sovversivi di risorse e solidarietà.
Oggi la sfida non è convincere la gente a rifiutarsi di vendere il proprio lavoro, ma dimostrare come una classe in esubero sia capace di sopravvivere e resistere. Di disoccupazione ne abbiamo in abbondanza: dobbiamo interrompere i processi che producono povertà.
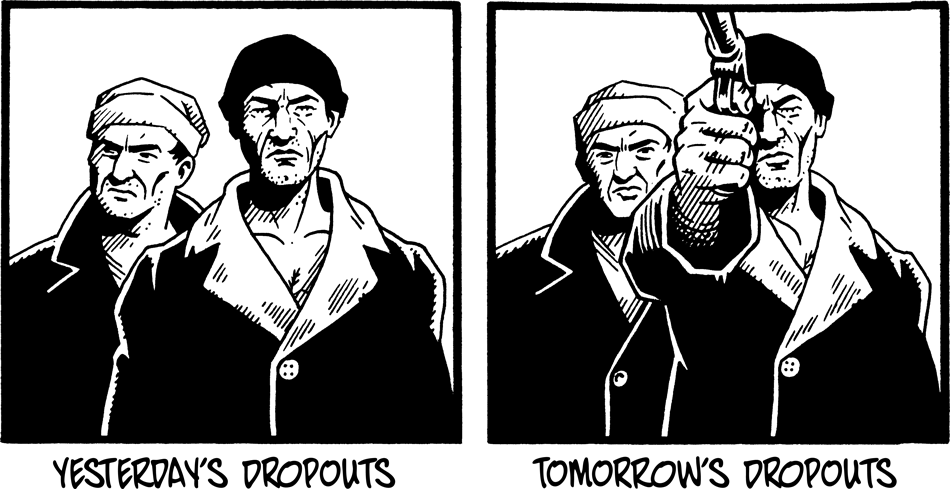
Tecnologie nuove – Strategie antiquate
Nella seconda metà del Ventesimo secolo, i radicali si erano organizzati in enclave sottoculturali dalle quali lanciavano attacchi contro la società. L’invito a praticare la disoccupazione conflittuale presupponeva un contesto di spazi controculturali in cui le persone potessero rendersi intimamente partecipi a qualcos’altro.
Oggi il orizzonte culturale è diverso, la stessa sottocultura sembra funzionare in maniera differente. Grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, si sviluppa e si diffonde molto più velocemente, e viene sostituita con altrettanta rapidità. Il punk rock, per esempio, non è più una società segreta alla quale gli studenti delle scuole superiori sono iniziati attraverso le musicassette registrate dai compagni di classe. È ancora partorito/ prodotto) da coloro che vi prendono parte, ma adesso funziona come un mercato di consumo ed è trasmesso attraverso luoghi impersonali, come le bacheche di annunci e i siti da cui scaricare brani musicali.
Non c’è da sorprendersi se le persone sono coinvolte meno intimamente: con la stessa facilità con cui lo hanno scoperto, possono passare a qualcos’altro. In un mondo fatto di informazione, la sottocultura non pare più al di fuori della società, a indicare una possibile via di fuga, ma si presenta come una delle molte zone al suo interno, una semplice questione di gusti.
Nel frattempo, Internet ha trasformato l’anonimato, un tempo prerogativa di criminali e anarchici, in un tratto aspetto tipico della comunicazione quotidiana. Eppure, inaspettatamente, organizza le identità e le posizioni politiche in base a una nuova logica. Lo scenario del discorso politico è tracciato in anticipo dagli URL: è difficile produrre un immaginario collettivo del potere e della trasformazione quando ogni affermazione è già inserita in una costellazione nota. Un manifesto su un muro può essere stato affisso da chiunque; sembra indicare un sentimento generalizzato, anche se rappresenta solo le idee di una persona. Una dichiarazione su un sito Internet, invece, compare in un mondo perennemente segregato in ghetti ideologici. L’immagine di CrimethInc. come movimento underground decentrato al quale chiunque poteva partecipare ha ispirato una miriade di attività, finché pian piano la topografia di Internet ha fatto sì che l’attenzione si concentrasse su un’unica pagina.
Così Internet ha parallelamente realizzato e reso obsolete le potenzialità che avevamo scorto nella sottocultura e nell’anonimato. Si potrebbe dire lo stesso della nostra perorazione del plagio. Dieci anni fa pensavamo di prendere una posizione estrema contro la paternità delle opere e la proprietà intellettuale, mentre in realtà eravamo precorrevamo appena l’evoluzione degli eventi. Le settimane spese a setacciare le biblioteche in cerca di immagini da riutilizzare prefiguravano un mondo in cui praticamente tutti fanno la stessa cosa per il proprio blog adoperando la funzione di ricerca immagini di Google. Il concetto tradizionale di paternità di un’opera è soppiantato da nuove forme di produzione, come il crowdsourcing, che indirizzano verso un possibile futuro in cui il lavoro volontario gratuito sarà una componente importante dell’economia – quale parte integrante del capitalismo, anziché forma di resistenza ai suoi valori.

E qui arriviamo a uno dei modi più nefasti in cui i nostri desideri hanno trovato realizzazione nella forma, più che nel contenuto. La distribuzione gratuita, un tempo considerata dimostrazione concreta di un’alternativa radicale ai modelli capitalistici, è ormai data per scontata in una società in cui i mezzi di produzione materiale sono ancora nelle mani dei capitalisti. I formati elettronici si prestano alla distribuzione gratuita delle informazioni; questo costringe chi produce formati materiali, come i quotidiani, a cederli o a cessare l’attività, per essere rimpiazzati da blogger felici di lavorare gratis. Al contempo, il cibo, l’alloggio e altre necessità della vita, per non parlare degli strumenti necessari per accedere ai formati elettronici, sono costosi come sempre. Questa situazione offre ai diseredati qualche possibilità di accesso a determinati beni a tutto vantaggio di coloro che già controllano vaste risorse: è perfetta per un’epoca di disoccupazione dilagante, in cui sarà necessario pacificare i farne uso. Implica un futuro in cui un’élite ricca userà il lavoro gratuito di un vasto insieme di lavoratori precari e disoccupati per preservare il proprio potere e la loro dipendenza.
L’aspetto più raccapricciante è che questo lavoro gratuito sarà assolutamente volontario, e darà l’impressione di portare benefici per tutti, invece che per l’elite.
Forse la contraddizione essenziale della nostra epoca è che le nuove tecnologie e forme sociali permettono di adottare un modello orizzontale di produzione e distribuzione delle informazioni, ma creano maggiore dipendenza dai prodotti delle multinazionali.
Decentramento della gerarchia: partecipazione come sottomissione
Alla fine degli anni Novanta gli anarchici sostenevano la partecipazione, il decentramento e l’azione individuale. Affidandoci alla nostra esperienza nel settore dell’autoproduzione alternativa, abbiamo contribuito a diffondere il modello virale, per cui un format sviluppato in un contesto può essere riprodotto in tutto il mondo. Esemplificato da programmi come Food Not Bombs e tattiche quali quella del Black Bloc, questo modello ha contribuito a diffondere una cultura antiautoritaria precisa da New York alla Nuova Zelanda.
All’epoca rispondevamo sia ai limiti dei modelli politici e tecnologici del secolo precedente sia alle opportunità emergenti per il loro superamento. Questo ci collocò all’avanguardia delle innovazioni che hanno rimodellato la società capitalista. Per esempio, TXTmob, il programma di elaborazione di SMS messo a punto dall’Institute for Applied Autonomy per le proteste in occasione delle Convention nazionali dei democratici e dei repubblicani, è servito da modello per Twitter. Allo stesso modo, le reti internazionali dell’autoproduzione alternativa, nella forma teorizzata in manuali quali Book Your Own Fucking Life, si possono considerare precursori di Myspace e Facebook. Nel frattempo, il modello virale si è oggi affermato soprattutto per il marketing virale.
La cultura dei consumi ci ha dunque catturati, integrando il nostro tentativo di fuga nel mantenimento dello spettacolo che avevamo rifiutato e offrendo a chiunque altro la possibilità di «evadere». Annoiato dalla programmazione a senso unico delle reti televisive, il consumatore moderno può provvedere alla propria programmazione personale, pur rimanendo a una distanza fisica ed emotiva dagli altri spettatori. Il nostro desiderio di maggiore capacità di intervento e partecipazione è stato esaudito, ma all’interno di un quadro ancora fondamentalmente determinato dal capitalismo. La pretesa che tutti diventino soggetti invece che oggetti è stata realizzata: siamo ora soggetti che gestiscono la propria alienazione, dando realtà alla massima situazionista secondo cui lo spettacolo non è solo il mondo delle apparenze, bensì il sistema sociale in cui gli esseri umani interagiscono soltanto in base ai ruoli prescritti.
Anche i fascisti stanno tentando la strada del decentramento e dell’autonomia. In Europa i «nazionalisti autonomi» si sono appropriati dell’estetica e dei format radicali, utilizzando la retorica anticapitalista e la tattica del black bloc. Di sicuro intorbida le acque, ma qui non si tratta soltanto dei nostri nemici che cercano di camuffarsi e assumere le nostre sembianze: è anche indice di una spaccatura ideologica nei circoli fascisti, allorché la generazione più giovane tenta di aggiornare i propri modelli organizzativi per adeguarli al Ventunesimo secolo. I fascisti negli Stati Uniti e altrove sono impegnati nello stesso progetto, sotto la bandiera paradossale dell’«anarchismo nazionale»; se riescono a convincere l’opinione pubblica che l’anarchia è una forma di fascismo, le nostre prospettive saranno davvero desolanti.

«Nazionalisti autonomi» (Qualcuno, per favore, ci liberi dall’afflizione di questi idioti!)
Che cosa significa se i fascisti, i principali fautori della gerarchia, possono utilizzare le strutture decentrate che siamo stati i primi a introdurre? Il Ventesimo secolo ci ha insegnato le conseguenze derivanti dall’uso di mezzi gerarchici per perseguire fini presumibilmente non autoritari. Il Ventunesimo secolo potrebbe indicarci come mezzi presumibilmente non gerarchici possano produrre esiti gerarchici.
Attingendo a questi e ad altri sviluppi, si potrebbe ipotizzare che ci stiamo muovendo verso una situazione in cui il fondamento della società gerarchica non sarà l’accentramento permanente del potere, ma la normalizzazione di alcune forme delegittimanti di socializzazione e di adozione delle decisioni e dei valori. Queste forme sembrano diffondersi spontaneamente, anche se in realtà paiono desiderabili in ragione di ciò che manca nel contesto sociale che ci viene imposto.
Ma che significa gerarchie decentrate? Sembra una specie di koan zen. La gerarchia è la concentrazione del potere nelle mani di pochi. Come può essere decentrata?
Per capirne il senso, occorre tornare alla concezione di Foucault del panopticon. Jeremy Bentham progettò il panopticon come modello per rendere più efficienti le carceri e i luoghi di lavoro; si tratta di un edificio circolare, nel quale tutte le stanze si affacciano su un cortile interno, in modo da poter essere viste da una torre di osservazione centrale. I detenuti non possono vedere ciò che accade nella torre, ma sanno di poter essere osservati dal suo interno in qualsiasi momento, sicché alla fine interiorizzano questa forma di sorveglianza e di controllo. In parole povere, il potere vede senza guardare, mentre l’osservato guarda senza vedere.

Panopticon
Nel panopticon il potere ha già sede in periferia, piuttosto che al centro, in quando il controllo è esercitato principalmente dai detenuti stessi. I lavoratori competono per diventare capitalisti, anziché fare causa comune come classe; i fascisti impongono autonomamente relazioni repressive, senza vigilanza da parte dello Stato. Il potere non è imposto dall’alto, ma in funzione della partecipazione stessa.
Semplicemente prendendo parte alla società, dobbiamo accettare la mediazione di strutture determinate da forze al di fuori del nostro controllo. Per esempio, le nostre amicizie passano sempre più attraverso Facebook, i telefoni cellulari e altre tecnologie che tengono traccia delle nostre attività e delle nostre relazioni a vantaggio delle multinazionali, oltre che dei servizi di informazione del governo; questi format determinano anche il contenuto delle amicizie stesse. Lo stesso vale per le nostre attività economiche: al posto della semplice povertà, abbiamo posizioni debitorie e creditizie – non siamo una classe priva di povertà, ma una classe guidata dal debito. E, ancora una volta, tutto questo appare come spontaneo, o addirittura come «progresso».
Come si prospetta l’idea di resistere in questo contesto? Le cose parevano molto più semplici nel 1917, quando i proletari di tutto il mondo sognavano di espugnare il Palazzo d’Inverno. Due generazioni dopo, l’equivalente sembrava essere prendere d’assalto le sedi delle emittenti televisive, una fantasia ripresa in un film di Hollywood non più tardi del 2005. Oggi è sempre più evidente che il capitalismo globale è privo di centro, di un cuore attraverso il quale drive a stake.
In realtà, questa evoluzione è una manna per gli anarchici, in quanto sbarra la strada a forme di lotta attuate dall’alto verso il basso. Non ci sono scorciatoie, oggi, né giustificazioni per prenderle – non ci saranno più dittature «provvisorie». Le rivoluzioni autoritarie del Ventesimo secolo sono per sempre alle nostre spalle; se dovrà scoppiare la rivolta, si dovranno diffondere le pratiche anarchiche.
Alcuni hanno sostenuto che, in assenza di un centro, quando il virus di cui sopra è molto più pericoloso dell’assalto frontale, il compito non è tanto scegliere il bersaglio giusto quanto pubblicizzare una nuova modalità di lotta. Se ciò non è ancora accaduto, forse è soltanto perché gli anarchici devono ancora mettere a punto un metodo che altri considerino pratico. Quando dimostriamo soluzioni concrete ai problemi sollevati dalla catastrofe capitalista, forse prenderanno piede.
Ma è un percorso insidioso. Tali soluzioni devono risuonare ben oltre qualsiasi sottocultura particolare in un’epoca in cui ogni innovazione istantaneamente genera sottocultura e vi rientra. Devono in qualche modo rifiutare e interrompere le forme di partecipazione essenziali al mantenimento dell’ordine, sia quelle basate sull’integrazione sia quelle basate sulla marginalità. Devono rispondere ai bisogni immediati delle persone, e al contempo ispirare desideri insurrezionali che conducano altrove. E se proponiamo soluzioni che rivelano di non affrontare le cause alla radice dei nostri problemi – come facemmo dieci anni fa – non faremo altro che vaccinare l’ordine dominante contro la resistenza di questa generazione.
Quando si tratta di soluzioni contagiose, magari come i disordini in Grecia nel 2008, durante i quali tutte le banche cui fu dato fuoco erano meno significative della pratica quotidiana in Grecia di occupare edifici, impossessarsi delle provviste alimentari e ridistribuirle e radunarsi in pubblico al di fuori della logica del commercio. O forse i tumulti furono altrettanto significativi: non solo un attacco materiale contro il nemico, ma una festa in cui si afferma un modo radicalmente diverso di esistere.
Destabilizzare la società: lascia o raddoppia
Negli anni ‘90 il capitalismo appariva per lo più stabile e inattaccabile. Gli anarchici fantasticavano di rivolte, catastrofi e del collasso industriale proprio perché sembrava impossibile che non avvenissero e perché, in loro assenza, sembrava non potessero che essere una buona cosa.
Tutto ciò cambiò a partire dal settembre 2001. Un decennio più tardi, le crisi e le catastrofi ci sono fin troppo familiari. L’idea che il mondo stia volgendo al termine è diventata sostanzialmente una banalità: chi non ha letto una relazione sul riscaldamento globale e poi fatto spallucce? L’impero capitalista è ovviamente troppo vasto e in pochi credono ancora che sia destinato a durare per sempre. Per ora, tuttavia, pare essere in grado di utilizzare queste catastrofi per consolidare il controllo, distribuendone i costi agli oppressi.
Via via che la globalizzazione intensifica la distanza tra le classi, alcune disparità tra le nazioni sembrano livellarsi. In Europa e negli Stati Uniti le strutture di sostegno sociale vengono smantellate proprio quando la crescita economica si sposta in Cina e in India, e uomini della Guardia Nazionale, che avevano combattuto in Iraq, sono stati impiegati negli Stati Uniti per mantenere l’ordine durante le proteste ai summit e nelle catastrofi naturali. Tutto questo è in linea con la tendenza generale ad allontanarsi da modelli gerarchici statici e territorializzati, tendenza che si dirige verso modelli dinamici e mezzi decentrati per mantenere le disuguaglianze. In questo nuovo contesto, i concetti del Ventesimo secolo sul privilegio e l’identità diventano sempre più semplicistici.
In tempi di globalizzazione e di decentramento, i nostri nemici della destra hanno già mobilitato la loro reazione. Lo vediamo col Tea Party negli Stati Uniti, nei movimenti nazionalisti in tutta Europa e, globalmente, nel fondamentalismo religioso. Mentre l’Europa occidentale si è agglomerata nell’Unione europea, la parte orientale è stata balcanizzata in decine di stati-nazione brulicanti di fascisti desiderosi di capitalizzare il malcontento popolare. Il fondamentalismo religioso è un fenomeno relativamente recente in Medio Oriente, che ha preso piede in seguito alle fallite “liberazioni nazionali” laiche e viene visto dall’imperialismo culturale occidentale come una reazione esagerata. Se permetteremo ai sostenitori della gerarchia di monopolizzare l’opposizione all’ordine dominante, gli anarchici scompariranno semplicemente dalla scena della storia.
In questa fase altri stanno già scomparendo. Mentre in Europa la classe media si assottiglia, muoiono con lei i partiti tradizionali della sinistra, e i partiti di estrema destra stanno prendendo il terreno lasciato libero.
Se la sinistra continua a recedere verso l’estinzione, a sinistra, per i radicali delle città, l’anarchismo sarà l’unica carta giocabile. Si aprirà uno spazio in cui potremmo essere in grado di proporre le nostre idee a tutti coloro che hanno perso la fiducia nei partiti politici. Ma siamo disposti a combattere contro il capitalismo globale da soli, senza alleati? L’escalation del conflitto è una scommessa: non appena ci attireremo l’attenzione dello Stato, dovremo raddoppiare la posta, cercando di mobilitare un sufficiente sostegno popolare per aggirare l’inevitabile contrattacco, oppure non farne nulla. Ogni rivolta deve essere seguita da una campagna di sensibilizzazione ancor più ampia, non essere un rifugio nell’ombra; un compito arduo di fronte alla reazione e alla repressione.
Forse sarebbe meglio se la storia si muovesse tanto lentamente da permetterci di avere il tempo di costruire un movimento popolare di massa. Purtroppo non ci può essere, in materia, una scelta. Pronti o no, l’instabilità che abbiamo desiderata è qui; provvederemo a cambiare il mondo o periremo con lui.
Quindi è giunto il momento di rinunciare a strategie fondate sulla stasi dello status quo. Allo stesso tempo, la crisi ci mantiene bloccati in un perpetuo presente, facendoci reagire a stimoli contingenti anziché agire strategicamente. Con le nostre capacità attuali, si può fare ben poco per attenuare gli effetti delle catastrofi capitalistiche. Il nostro compito è piuttosto quello di provocare reazioni di rivolta a catena; dobbiamo valutare tutto ciò che intraprendiamo in questa luce.
In questo contesto, è più importante che mai vedere noi stessi come protagonisti dell’insurrezione. Il corpo sociale anarchico attualmente esistente negli Stati Uniti è abbastanza numeroso per catalizzare sconvolgimenti sociali, ma non così corposo da realizzarli. Come uno dei compagni di Void Network non si stanca di ripetere: “Noi non facciamo l’insurrezione. Facciamo solo un po ‘di organizzazione: ognuno fa l’insurrezione”.
Ciò richiederà molto da ciascuno di noi. Diecimila anarchici disposti a mettersi sulla stessa lunghezza d’onda di Enric Duran, santo patrono dei debitori morosi, potrebbero costituire una forza reale, raccogliendo le risorse con cui costruire infrastrutture alternative e dando un esempio di disobbedienza pubblica che potrebbe diffondersi in lungo e in largo. Quella è una cosa che potrebbe aggiornare il “dropping out” per questa nuova epoca. E’ terrificante immaginare di arrivare a punti del genere, ma in un mondo al collasso il terrore ci aspetta comunque, che ci vada bene o meno.
Tutti quelli che hanno partecipato ad un black block sanno che è più sicuro stare davanti. Lascia o raddoppia.
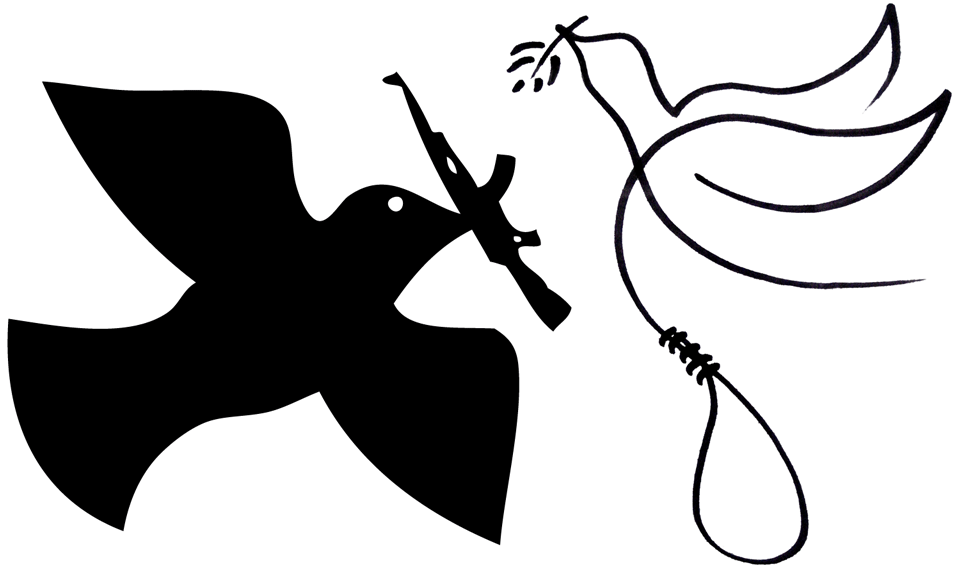
E conclusione. Piaceri proibiti
Ma basta parlare di strategia. C’era una richesta in Days of War, Nights of Love, che in nessuna forma potrebbe essere realizzata sotto il capitalismo: l’idea che la vita senza mediazioni possa diventare intensa e gioiosa. Nella nostra concezione di resistenza l’abbiamo espressa come un’avventura romantica in grado di soddisfare tutti i desideri prodotti, ma mai consumati nella società dei consumi. Nonostante tutta la tribolazione e la sofferenza degli ultimi dieci anni, questa sfida aleggia ancora come la speranza in fondo al vaso di Pandora.
Continuiamo a ribadire questa richiesta. Noi non resistiamo solo per dovere, abitudine o sete di vendetta, ma perché vogliamo vivere pienamente e far rendere al meglio il nostro potenziale illimitato. Siamo rivoluzionari anarchici, perché sembra non ci sia modo di scoprire cosa significa senza lottare almeno un po’.
Per quante difficoltà possa comportare, la nostra lotta è una ricerca della gioia; per essere più precisi, si tratta di un modo per creare nuove forme di gioia. Se perdiamo di vista questo, nessun altro si unirà a noi e nemmeno dovrebbero. Godersela non è semplicemente qualcosa che dobbiamo fare per essere strategici, per attirare simpatizzanti: è un segno infallibile per capire se abbiamo o no qualcosa da offrire.
Man mano che l’austerità diventa la parola d’ordine dei nostri governanti, i piaceri disponibili sul mercato saranno sempre più dei surrogati. L’interesse per la realtà virtuale vuol dire praticamente ammettere che la vita reale non è, non può essere appagante. Dobbiamo dimostrare il contrario, scoprendo i piaceri proibiti che indicano la strada per un altro mondo.
Ironia della sorte, dieci anni fa questa domanda sensata è stata l’aspetto più controverso del nostro programma. Nulla mette le persone più sulla difensiva che il suggerimento che possono e devono divertirsi: innesca tutta la vergogna dell’incapacità di farlo, tutto il risentimento verso quelli che sentono come i monopolizzatori del piacere, e una gran quantità di puritanesimo persistente.
In Frammenti di un antropologia anarchica, David Graeber ipotizza che:
”se si vuole ispirare odio etnico, il modo più semplice per farlo è concentrarsi sui modi bizzarri, perversi, in cui l’altro gruppo avversario persegue il piacere. Se si vuole sottolineare comunanza, il modo più semplice sta nel sottolineare che anche loro provano dolore”.
Questa formula è tragicamente familiare a chi abbia visto i radicali sfottersi a vicenda. Dichiarare di aver provato un piacere celestiale – soprattutto per qualcosa che viola di fatto il regime di controllo, come il taccheggio o gli scontri con la polizia – è un invito a farsi rovesciare addosso disprezzo. E forse questa formula spiega anche perché gli anarchici possono trovarsi quando lo stato uccide Brad Will o Alexis Grigoropoulos, ma non riescano a mettere da parte le loro differenze per combattere altrettanto ferocemente per i vivi.

La morte ci mobilita, ci catalizza. La memoria della nostra mortalità ci libera, ci permette di agire senza paura; nulla è più terrificante della possibilità che si possano vivere i nostri sogni, che qualcosa è veramente in gioco nella nostra vita. Se solo sapessimo che il mondo sta finendo, si sarebbe finalmente in grado di rischiare tutto, non solo perché non avremmo niente da perdere, ma perché non si avrebbe più nulla da vincere.
Ma se vogliamo essere anarchici, dobbiamo abbracciare la possibilità che i nostri sogni possano divenire realtà, e lottare di conseguenza. Per una volta dovremo scegliere la vita invece della morte, il piacere invece del dolore. Dovremo cominciare ad iniziare.


